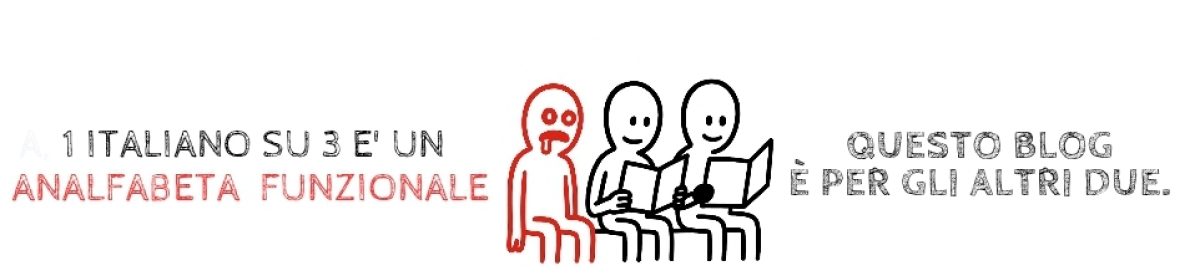Scrivere oggi della strage di Piazza Fontana non è un esercizio commemorativo: è un atto politico. È un rifiuto dell’oblio, un rifiuto della verità addomesticata, un rifiuto della narrazione tossica che per anni lo Stato e i suoi apparati hanno tentato di imporre. Il 12 dicembre 1969 la bomba alla Banca Nazionale dell’Agricoltura non esplose solo in quell’edificio: colpì il cuore della Repubblica, aprì la stagione della strategia della tensione, marcò un solco tra ciò che l’Italia diceva di essere e ciò che realmente stava diventando.
La verità è ormai storicamente chiara: la strage fu opera della destra neofascista, di quei gruppi che sognavano un’“Italia forte”, autoritaria, militarizzata, e che con l’appoggio di segmenti dei servizi segreti occidentali miravano a costruire un clima di caos e paura. A rendere tutto più oscuro furono i depistaggi degli apparati statali, che manipolarono prove, inventarono piste, fabbricarono colpevoli improvvisati. In mezzo, come bersaglio perfetto, fu scelto chi incarnava l’antitesi naturale del fascismo: gli anarchici.
È qui che entra in scena il Circolo anarchico Ponte della Ghisolfa, non una tana di terroristi – come fu dipinto dai media di allora – ma un luogo di creatività politica, dibattito, solidarietà e critica radicale del potere. Era un crocevia di idee e di vite che immaginavano una società diversa: senza padroni, senza gerarchie, senza Stato. In un Paese attraversato da nostalgie autoritarie, quel circolo era un faro libertario. E proprio per questo divenne un capro espiatorio perfetto.
La notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969 Giuseppe Pinelli, ferroviere anarchico, marito e padre, fu assassinato, cadde dal quarto piano della Questura di Milano mentre veniva interrogato illegalmente, senza un avvocato, senza un’accusa formalizzata, senza un verbale. La versione ufficiale fu una delle pagine più buie della storia repubblicana. Pinelli non era un terrorista: era un anarchico impegnato, un uomo pulito, un compagno rispettato. La sua morte è un simbolo indelebile della violenza di Stato.

A finire nel tritacarne mediatico fu anche Pietro Valpreda, ballerino e anarchico. Un uomo con idee scomode, perfetto per essere trasformato nel mostro da prima pagina. È lui! titolavano i giornali prima ancora che un giudice si pronunciasse, in un clima di caccia all’anarchico che ebbe toni apertamente fascistoidi. Valpreda fu incarcerato per anni, innocente, mentre i veri colpevoli neofascisti restavano ai margini delle prime pagine.

Nel frattempo, settori deviati dello Stato alimentavano una narrazione costruita: l’Italia doveva credere che gli anarchici fossero violenti, irrazionali, pericolosi. Era funzionale a un progetto più grande: far dimenticare chi fossero i veri responsabili. Per questo ricordare è un atto di resistenza. Perché la memoria non è neutrale. È un terreno di conflitto. E chi dimentica è complice, complice della menzogna, complice della rimozione, complice del silenzio che fa comodo a chi quei giorni li voleva cancellare.
La memoria di Piazza Fontana non è solo un dovere morale: è una forma di auto-difesa civile contro il ritorno del fascismo in tutte le sue forme, vecchie e nuove. Ricordare Pinelli significa ricordare tutte le vittime della violenza istituzionale. Ricordare Valpreda significa opporsi ai processi sommari, alla disinformazione, alla logica del capro espiatorio. Ricordare il Circolo Anarchico Ponte della Ghisolfa significa riconoscere che l’anarchismo è stato, e continua a essere, una delle poche voci capaci di opporsi frontalmente al potere quando diventa oppressivo.
Ricordare non è un gesto sterile: è schierarsi.
E chi non si schiera, chi non ricorda, chi minimizza, diventa complice.
Anche leggere diventa un’azione di lotta e di memoria. Questi tre libri possono fare la differenza tra essere indifferenti e lottare ricordando.
La strage di Stato. Controinchiesta
Pubblicato nel 1970, questo dossier è il testo fondamentale dell’informazione alternativa sulla strage. La strage di Stato non è solo un libro: è un atto politico, una controinchiesta che sfida apertamente la versione ufficiale. Il volume ricostruisce gli intrecci tra gruppi neofascisti come Ordine Nuovo, settori dei servizi segreti militari, influenze della CIA e la volontà strategica di creare disordine per spingere l’Italia verso un governo autoritario. Gli autori portano alla luce documenti, testimonianze e omissioni che mostrano come gli anarchici siano stati usati come copertura. È un libro da leggere oggi più di ieri, perché dimostra come il fascismo possa indossare la maschera dello Stato stesso. Un’opera imprescindibile.

È lui! Pietro Valpreda. Diario dalla galera 1969-1972
Il diario di Valpreda è un pugno nello stomaco. Racconta la violenza psicologica, le umiliazioni, la solitudine, ma anche la dignità anarchica di chi non si piega. Il titolo – È lui! – riprende la frase con cui l’opinione pubblica fu manipolata nelle ore successive alla strage. Nel testo emergono la costruzione del “nemico interno”, il ruolo della stampa pilotata, il clima di sospetto verso chiunque si opponesse all’autoritarismo. Valpreda offre una testimonianza che non è solo personale, ma storica e politica: il suo diario è la prova vivente di come lo Stato possa creare un colpevole quando gli serve. Un libro necessario per comprendere l’intreccio tra fascismo culturale e repressione del dissenso.

Pinelli. Una storia di Paolo Pasi
Paolo Pasi ricostruisce con precisione e rispetto la vita di Giuseppe Pinelli, restituendogli ciò che la propaganda gli aveva sottratto: la sua umanità e il suo impegno politico. L’autore affronta la morte di Pinelli senza retorica ma con radicalità, mostrando come la versione ufficiale non regga alla prova dei fatti. Il libro illumina il contesto del movimento anarchico milanese, il ruolo del Ponte della Ghisolfa, la rete di solidarietà che Pinelli aveva contribuito a costruire. È un testo che aiuta a capire perché la sua morte è divenuta un simbolo di ingiustizia e perché la memoria di Pinelli rimane un atto politico. Una lettura che fa male ma necessaria.

Ricordare Piazza Fontana significa rifiutare ogni revisionismo.
Significa dire che i fascisti furono responsabili e che gli apparati statali furono complici, depistarono, coprirono, tradirono la verità.
Significa riconoscere che gli anarchici furono l’unica voce limpida in una storia di menzogne.
La memoria è un’arma.
E chi dimentica è complice.