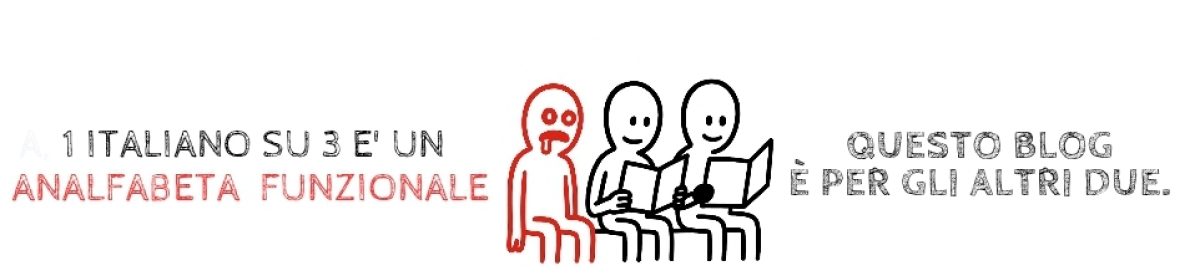Il 19 novembre 2025, centenario della nascita di Zygmunt Bauman, ci trova immersi in un paesaggio culturale che lui aveva intuito, ma che forse non avrebbe immaginato così estremo. Nella sua Modernità liquida, Bauman descriveva una società dove tutto scorreva troppo velocemente per costruire identità solide. Eppure, l’era dei social è andata oltre: ha fatto evaporare perfino la parte liquida, lasciando dietro di sé non un mare in tempesta, ma una vera e propria desertificazione del pensiero critico, un terreno arido su cui crescono solo slogan, reazioni impulsive e identità politiche prefabbricate dagli algoritmi.

Gli algoritmi hanno sostituito la riflessione. Hanno preso persone che non conoscono la storia, non leggono, non contestualizzano la geopolitica, e le hanno trasformate in tifosi inconsapevoli: convinti di essere di destra o di sinistra solo perché i feed li nutrono di contenuti costruiti su misura per rafforzare ciò che già credono di credere. Non è un pensiero politico: è una sensazione politica, una bolla emotiva di secondi, non di idee.
E così, mentre si moltiplicano gli autodidatti dell’“ho visto un video e ora so come funziona il mondo”, cresce anche la frustrazione di chi osserva questo declino culturale. Una frustrazione così intensa da generare — provocatoriamente, ma sempre più spesso — l’idea che il suffragio universale andrebbe rivisto, che la democrazia richieda almeno il minimo sindacale di competenze per essere esercitata. Dall’altra parte, c’è chi propone un “patentino cognitivo” per accedere ai social, così da evitare che gli algoritmi amplifichino l’ignoranza come se fosse informazione.
Dal punto di vista di chi formula queste idee radicali, il ragionamento è lineare: se la maggior parte delle persone costruisce le proprie opinioni politiche su una dieta di video da otto secondi, meme e disinformazione virale, allora lasciare che tutto ciò influenzi le scelte collettive sembrerebbe una forma di autolesionismo pubblico. In quest’ottica estrema, più che un atto autoritario, tali soluzioni appaiono come tentativi disperati di difendere ciò che resta della capacità critica della società.
Naturalmente, nella realtà concreta, limitare i diritti democratici o l’accesso alle piattaforme sembrerebbe pericoloso e contrario ai principi fondamentali della convivenza civile. Ma il fatto stesso che simili idee emergano e vengano prese in considerazione è il segnale che qualcosa si è rotto: non siamo più nella modernità liquida, ma nella modernità evaporata, dove l’aridità cognitiva è diventata la condizione dominante, e dove la complessità è percepita come una minaccia, non come una risorsa.
In questo scenario, Bauman ci offrirebbe probabilmente la stessa risposta che avrebbe dato decenni fa: non si risolve la crisi culturale togliendo voce a chi ce l’ha, ma restituendo strumenti a chi ne è stato privato. Educazione critica, lentezza, studio, approfondimento, capacità di convivere con l’incertezza: queste erano le sue bussole, e oggi sembrano quasi rivoluzionarie.
Nel giorno del suo centenario, la lezione rimane la stessa: nessun algoritmo, nessun reel, nessun video di otto secondi ci darà mai la comprensione del mondo. Per capirlo serve esattamente ciò che la desertificazione digitale ci ha sottratto: complessità, memoria, consapevolezza. In altre parole, serve ciò che Bauman ha cercato di insegnarci per tutta la vita.